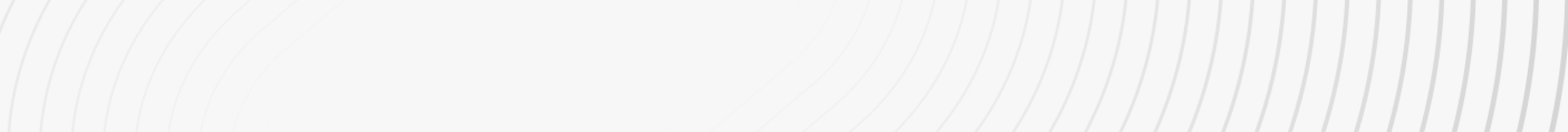Canestro
Canestro
Derrick Rose: la storia di un campione resiliente
Ci sono carriere che si misurano in trofei. E poi ci sono storie come quella di Derrick Rose, che si misurano in cadute, silenzi e rinascite. Talento purissimo cresciuto tra i playground di Chicago, Rose ha toccato il cielo a 22 anni diventando l’MVP più giovane nella storia dell’NBA — per poi sprofondare nell’inferno degli infortuni. Ma ciò che ha reso la sua parabola unica non è stato l’apice, bensì la forza con cui ha continuato a rialzarsi, ogni volta. Questa è la storia completa di D-Rose: da ragazzo di Englewood a simbolo vivente di resilienza.
Chi era Derrick Rose prima di diventare D-Rose
Prima di diventare il giocatore più giovane a vincere il titolo di MVP nella storia dell’NBA, Derrick Rose era solo un ragazzo di Englewood, uno dei quartieri più difficili e violenti di Chicago. Cresciuto dalla madre Brenda, una donna forte e determinata, e protetto dai suoi tre fratelli maggiori, Derrick imparò presto che per restare lontano dai guai serviva disciplina — e un pallone da basket sempre tra le mani.
In quel contesto ostile, la pallacanestro non era solo uno sport: era una via di fuga, un rifugio, una speranza concreta. I primi palleggi li faceva sul cemento dei playground, ma già da bambino mostrava una rapidità e un controllo fuori dal comune. Frequentò la Simeon Career Academy, una scuola molto importante per il basket liceale di Chicago, dove vestì il numero 25 in onore di Benji Wilson, un talento locale tragicamente scomparso.
Lì, Derrick diventò subito un punto fermo: due titoli statali consecutivi, giocate da leader consumato e un’umiltà che spiazzava chiunque lo incontrasse fuori dal campo. Non parlava molto, ma il suo gioco diceva tutto. Chi lo conosceva già lo chiamava “Pooh”, per il suo volto gentile (si dice sia stata la nonna a darglielo per prima). Ma in campo, era già una tempesta in costruzione.
Derrick Rose sbarca in NBA
Dopo aver incantato i licei dell’Illinois, Derrick Rose scelse di restare fedele al suo stile silenzioso ma devastante: niente luci di Hollywood, niente college “di moda”. Accettò l’offerta dell’Università di Memphis, guidata da coach John Calipari, e in pochi mesi trasformò i Tigers in una macchina da guerra. Con Rose in regia, Memphis volò a 38 vittorie stagionali — record assoluto all’epoca — e arrivò a sfiorare il titolo NCAA 2008, perso solo in overtime contro Kansas.
Quel breve ma dominante anno universitario bastò a far capire a tutti che Rose era un talento diverso. Non solo veloce: intelligente, istintivo, determinato. Non parlava quasi mai con i media, ma in campo parlava eccome. Al Draft NBA del 2008, nessuno aveva più dubbi. Quando i Chicago Bulls ottennero la prima scelta assoluta, sembrava scritto: Derrick sarebbe tornato a casa.
Chicago abbracciò il suo nuovo figlio prediletto come l’erede di una legacy pesante. Nessuno osava paragonarlo a Jordan, ma tutti vedevano in lui il volto nuovo della speranza. E Derrick, per un po’, fu davvero all’altezza di quella speranza.
In NBA arriva un marziano: la stagione della leggenda D-Rose
Il debutto di Derrick Rose in NBA fu tutto ciò che Chicago sognava: 16,8 punti e 6,3 assist di media, titolarità immediata e una maturità che non sembrava di un rookie. A fine stagione, vinse il premio di Rookie dell’anno e incantò tutti ai playoff con 36 punti nella sua prima partita contro Boston — un record per un debuttante. In tre stagioni, passò da giovane promessa a leader indiscusso dei Bulls, crescendo in statistica, responsabilità e carisma.
Nel 2010–11, a soli 22 anni, Rose scrisse la sua pagina nella storia. Guidò i Bulls al miglior record NBA (62–20), sfidando da solo le superpotenze costruite a tavolino. Giocava con grazia e ferocia, con il controllo di un veterano e l’istinto di un predestinato. Chiudeva partite, affondava penetrazioni impossibili, alzava il livello di tutti.
A fine stagione, arrivò la consacrazione: MVP della regular season, il più giovane di sempre. Derrick Rose non era solo un fenomeno atletico. Era diventato il simbolo di una città ferita e affamata di riscatto, e lo faceva senza proclami, con uno stile tutto suo: umile, silenzioso, letale. Per un istante, sembrava che nulla potesse fermarlo.
Gli infortuni e i problemi fisici di Rose
Il 28 aprile 2012, in gara-1 dei playoff contro Philadelphia, con i Bulls avanti e pochi minuti da giocare, si spense la luce. Derrick Rose si accasciò sul parquet dopo un arresto e partenza apparentemente innocua. In un attimo, l’atmosfera di festa si spense. La diagnosi fu brutale: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il più giovane MVP di sempre veniva colpito all’apice. E non sarebbe più stato lo stesso.
Quello fu l’inizio di una lunga e tormentata discesa. Saltò l’intera stagione 2012–13. Tornò nel 2013, ma dopo poche partite si lesionò il menisco del ginocchio destro. Operazione. Nuova stagione persa. Tornò nel 2014, ma ancora infortuni. Ancora operazioni. Il suo corpo sembrava tradirlo ogni volta che provava a rialzarsi. In tre anni, due interventi chirurgici alle ginocchia, una maschera protettiva indossata, quasi 200 partite saltate, e una domanda sospesa su ogni parquet: tornerà mai il vero Derrick Rose? La risposta è stata lunga, dolorosa, e mai definitiva.
Derrick ci ha provato. Ha lasciato Chicago nel 2016, trasferendosi a New York con la voglia di ripartire. Ma anche lì, tra buone prestazioni e nuovi stop, arrivò un altro menisco rotto. Poi Cleveland, un’esperienza caotica e cupa, durante la quale si prese una pausa dal basket per riflettere se ritirarsi del tutto. I media lo davano per finito. Molti ridevano della sua parabola spezzata. Lui restava in silenzio. Poi, nel 2018, accadde qualcosa.
Firmò con i Timberwolves. Ritrovò Tom Thibodeau, l’allenatore dei suoi giorni migliori. E in una notte d’ottobre, davanti a un pubblico che non lo conosceva ancora davvero, mise a segno 50 punti contro gli Utah Jazz. Lacrime. Applausi. Abbracci. Il ritorno del D-Rose MVP? No. Ma il ritorno dell’uomo che non ha mai smesso di provarci.
Da lì in poi, Derrick Rose ha vissuto tante “piccole rinascite”. A Detroit, come sesto uomo. A New York, di nuovo, come mentore e trascinatore. Ai playoff 2021 fu spesso il miglior Knick in campo. I tifosi cantavano “MVP” ogni volta che entrava. E non perché ci credessero davvero, ma perché lo onoravano. Non per quello che faceva, ma per quello che aveva passato.
Non è più tornato l’atleta imbattibile del 2011. Il tempo non gliel’ha concesso. Ma è diventato qualcosa di diverso: un simbolo di resilienza, di dignità, di umanità sportiva. Si è adattato, ha accettato ruoli minori, ha giocato per squadre giovani, ha fatto da guida silenziosa. E ogni tanto, quando le ginocchia lo lasciavano in pace, mostrava ancora lampi del vecchio fuoco. Non serviva altro.
Quella di Derrick Rose non è una favola con il lieto fine classico. Non c’è l’anello, né il ritorno trionfale. Ma c’è qualcosa di più raro: la forza di rialzarsi, ogni volta, anche quando nessuno guarda. In un mondo che misura tutto in vittorie, lui ha ricordato a tutti che a volte il successo è semplicemente non mollare mai.
Il ritorno a Memphis: il ritiro di Derrick Rose
Ogni storia ha una fine. E quella di Derrick Rose si è chiusa lontano dalle luci del Madison Square Garden, senza il clamore dei titoli o le standing ovation da superstar. Si è chiusa a Memphis, dove anni prima era esplosa la sua leggenda universitaria, in un cerchio perfetto e silenzioso.
Nel 2025, dopo 16 stagioni, quattro interventi chirurgici e innumerevoli ritorni, Derrick Rose ha detto basta. Lo ha fatto con la stessa grazia con cui ha sempre affrontato il dolore: senza clamore, ma con parole vere. Il ragazzo nato dall’asfalto di Englewood, esploso con la maglia dei Bulls, ha chiuso la sua corsa al tramonto in Tennessee. Non da MVP, ma da uomo. Non come leggenda intoccabile, ma come testimone vivente di ciò che significa cadere e continuare a camminare lo stesso. E forse è proprio per questo che Derrick Rose non verrà mai dimenticato.